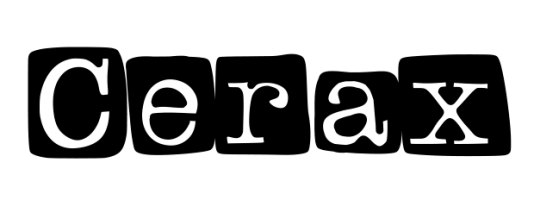Quando arrivammo a Sarajevo fummo accolti dal suono inconfondibile dei minareti. Era intorno a mezzogiorno, ora del “salatu-l-zuhr”. Il secondo richiamo alla preghiera. Il sole era allo zenit ed il termometro dell’auto segnava 42 gradi, non uno di meno. Sudavamo, tanto. Un dettaglio. Minimo. Ficcato a caso in quello che racconto perché rende perfettamente l’idea di come, dinanzi alla curiosità e al brivido dell’ avventura, finanche il più noioso dei fastidi finisca tra le note a margine delle nostre esperienze. All’ultima pagina. Quella dei ricordi spremuti. Delle sfumature insignificanti.
La strada che ci aveva condotto lì, che ben mi riguardo dal chiamare autostrada (nella nostra accezione), terminava tra una selva di altissimi edifici prefabbricati di costruzione recente attraversati da ampie e curate carreggiate. Periferia occidentale. Tutta, schifosamente uguale. A Sarajevo come a Napoli. Roma, Parigi, Berlino. Potevamo essere ovunque.
Vagammo a lungo in direzione del centro città. A passo lento, guardando con occhio malato ogni singola costruzione che sfilava dal nostro sguardo lungo il percorso. Ogni facciata, edificio, piazza. Ovunque potesse esservi traccia. Eravamo parecchio lontani dalla verginità di occhi che abbracciano per la prima volta dei luoghi. I nostri erano pesanti, affamati. Deformi. Cercavamo qualcosa in particolare. Qualcosa che saziasse quel macabro desiderio.
Qualche foro di proiettile. Delle targhe commemorative e decine e decine di negozi di souvenir colmi di bossoli, tute mimetiche e vomito bellico. Nulla. Certo non era Las Vegas, ma neanche l’ultimo villaggio africano. H&M, Pull&Bear, McDonald’s. Banche, strade dello shopping e parcheggi orari. Nel cuore della capitale, intricate stradine lastricate da sanpietrini s’incrociavano, bagnate dall’odore d’incenso dei tanti bazar. 2,3 forse 4 moschee nel raggio di 100 metri. Burqa integrali, veli e minigonne. Tutto meravigliosamente assieme.

Delusi, ci sedemmo al tavolo di un bar di fortuna. Erano passate oltre 2 ore. Ordinammo cevapici. Un piatto tipico dei balcani. Salsiccette con pane e cipolle, non male. Non appena avemmo concluso, un ragazzone col grembiule si avvicinò al nostro tavolo e ci mise il conto davanti. Approfittai. Chiesi di 20 anni prima. Di dove fossero finite le case distrutte. I cimiteri dei caduti. I punti strategici. Le bombe. Insomma, quello che i nostri occhi cercavano con insistenza sin da principio. Non capì una parola. Manco mezza. Parlava a stento la sua lingua. Lo liquidammo.
Al tavolo accanto al nostro sedeva una coppia di donne sulla cinquantina. Ci osservarono a lungo. Sorseggiavano dalle loro tazze curiosando trai nostri deliranti discorsi. Non appena il cameriere si fu allontanato una delle due incrociò il mio sguardo e azzardò qualche parola d’inglese. Aveva compreso. Cominciò a raccontare. Parola dopo parola le si spensero gli occhi. Raccontò dei ricoveri. Delle bombe che cadevano a pioggia. Della fame e dei familiari scomparsi. Dei cecchini. Che non facevano differenza tra quelli in divisa e quelli con un pallone trai piedi. 5,6,7 anni. Vite spente ancor prima di cominciare davvero. Non pianse, si trattenne. Il suo sguardo però parlava meglio del suo inglese. Calò il gelo. Ci diede delle indicazioni su cosa visitare. “Andate e guardate da voi”.
Della Sarajevo che volevamo non c’era più nulla. Ciò che restava era tutto negli occhi spenti di quella donna. Nelle sue parole tremanti.
Nel diluvio che ci accompagnò quando tornammo in auto per viaggiare verso casa.